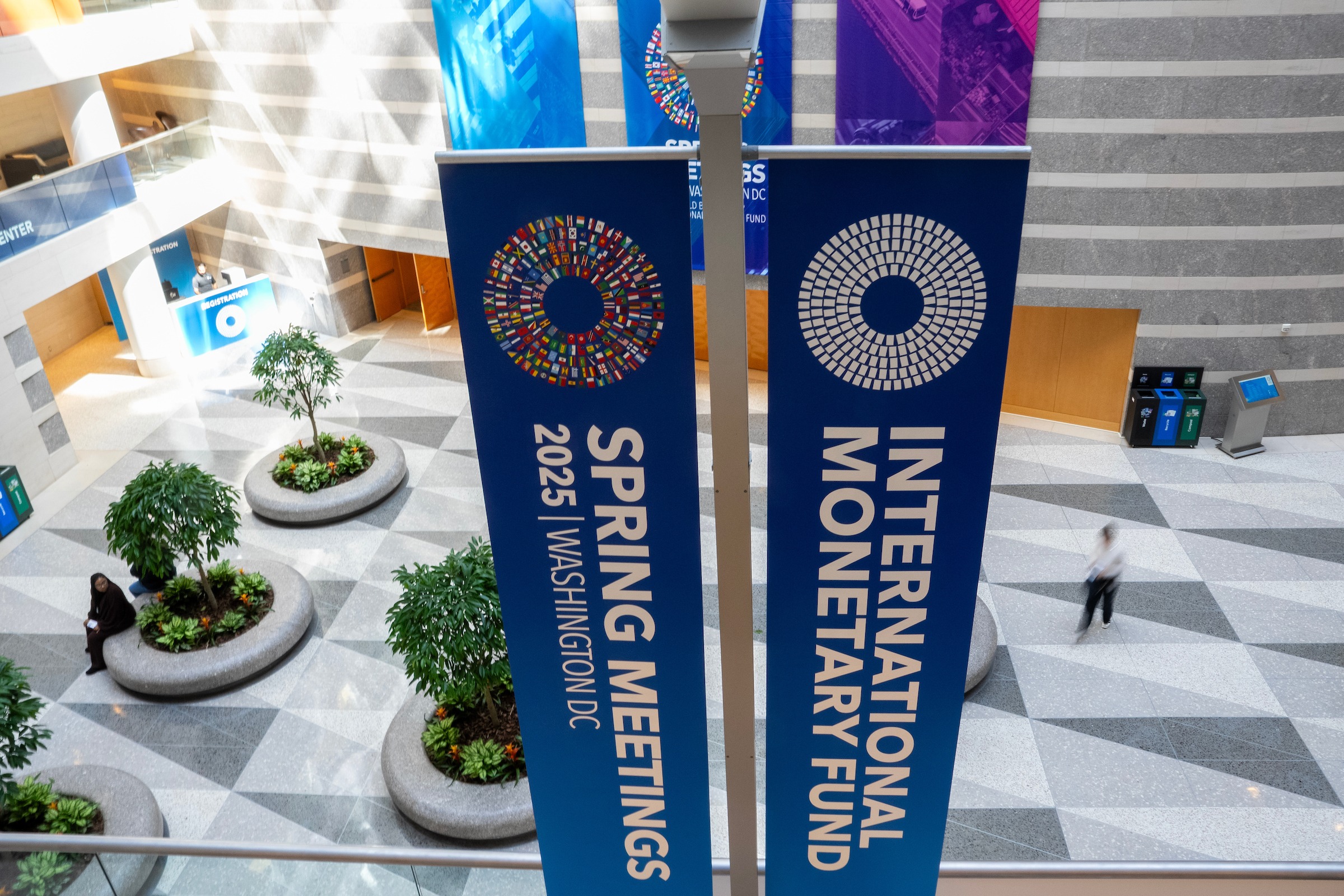“Incertezza” è stata la parola chiave che ha dominato gli Spring Meetings 2025 di Fondo Monetario Internazionale (FMI) e Banca Mondiale che si sono tenuti a Washington DC dal 21 al 26 aprile. Non ha stupito che il FMI abbia annunciato una revisione al ribasso delle prospettive di crescita globale e che entrambe le istituzioni abbiano espresso allarme per il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo. Ha sorpreso però che il tema dei dazi doganali, vero e proprio elefante nella stanza, e causa fondamentale dell’accresciuta instabilità globale, è stato appena accennato nei comunicati ufficiali, nonostante i loro effetti potenzialmente devastanti, soprattutto per i Paesi a basso reddito (LICs).
L’economia globale pre-Trump era già caratterizzata da debiti pubblici in crescita e forti pressioni fiscali, ma l’attuale incertezza geopolitica e commerciale sta contribuendo a frenare gli investimenti e peggiorare l’accesso al credito, soprattutto nei paesi più poveri. Molti Paesi continuano a trovarsi davanti al bivio: onorare il servizio del debito o investire in sviluppo sostenibile e azione climatica?
La nuova strategia commerciale degli Stati Uniti – azionisti di maggioranza delle istituzioni di Bretton Woods – rendono la situazione ancora più complessa. La minaccia dell’imposizione di dazi per imporre i propri beni, legati alle fonti fossili, nei mercati globali, rischia di compromettere le prospettive di crescita e lo sviluppo di filiere di energia pulita nei Paesi in via di sviluppo. Investimenti, questi, spesso sostenuti ricorrendo al debito pubblico o garantito, che rischiano di finanziare stranded assets, in un orizzonte temporale sempre più ravvicinato. Il risultato è un ulteriore aggravamento del rischio di insostenibilità del debito per molti Paesi, soprattutto africani, che rischiano di rimanere intrappolati in infrastrutture obsolete e finanziariamente rischiose.
Spring Meetings 2025: condizionamenti politici che influenzano l’ambizione climatica
La principale novità degli Spring Meetings 2025 sono state le parole del Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, che lasciano poco spazio a interpretazioni: il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale dovrebbero tornare ai “fondamentali”, concentrandosi su stabilità macroeconomica e disciplina fiscale, riducendo l’attenzione verso le tematiche climatiche, sociali e di genere. Un approccio che, oltre a mettere in discussione il ruolo delle istituzioni finanziarie multilaterali nel sostenere la transizione energetica, rischia di minare la già fragile cooperazione internazionale.
In risposta a queste affermazioni, l’ambizione climatica sembra gradualmente arretrare anche ai vertici delle stesse istituzioni finanziarie. La direttrice del FMI, Kristalina Georgieva, ha evitato di affrontare esplicitamente il tema, parlando invece della necessità di aiutare i Paesi più vulnerabili a gestire i rischi economici derivanti da “eventi meteorologici estremi”. L’attenzione si è poi rapidamente spostata su dossier più politici, come il controverso sostegno al Governo argentino, a pochi mesi dalle elezioni, con un nuovo pacchetto di prestiti da 20 miliardi di dollari approvato senza passaggio parlamentare.
La Banca Mondiale, dal canto suo, continua a inviare segnali contraddittori: da un lato il presidente Ajay Banga ribadisce l’impegno dell’istituzione verso i finanziamenti climatici, dall’altro introduce un approccio “all of the above” in ambito energetico, che include espressamente gas naturale e, per la prima volta dopo anni, energia nucleare. Questo orientamento sarà formalizzato nella nuova strategia energetica della Banca, attesa per l’approvazione da parte del Consiglio esecutivo a giugno. Un cambio di rotta che solleva interrogativi sulla coerenza degli impegni assunti dalla Banca con l’obiettivo di allineare i suoi finanziamenti agli Accordi di Parigi.
In questo quadro si inserisce il recente accordo siglato con dalla Banca Mondiale con l’Italia, che rafforza la cooperazione tra le due parti per promuovere lo sviluppo in Africa. L’intesa rende ufficiale l’incremento del 25% del contributo italiano all’IDA, il fondo della Banca destinato ai Paesi più poveri, e sostiene il Piano Mattei, con investimenti mirati in energia, infrastrutture, salute, istruzione e formazione. La partnership punta a co-finanziare progetti ad alto impatto, in linea con iniziative come Mission 300 per l’accesso all’elettricità, ma resta da chiarire quanto queste azioni riusciranno a bilanciare le esigenze di sviluppo e l’effettiva transizione verso un modello energetico sostenibile.
Dal G20 alla COP30 in cerca di soluzioni e multilateralismo. L’Italia alla guida del gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile con la Cina
Il 2025 si conferma un anno di transizione anche per il G20, guidato da un Sudafrica alle prese con tensioni politiche interne e pressioni esterne. La recente proposta di bilancio del Governo ha generato malcontento nel Paese, mentre sul fronte internazionale Pretoria si è trovata a dover gestire le critiche, anche pubbliche, da parte degli Stati Uniti sul contenuto e l’impostazione della sua agenda G20. In questo contesto, l’Italia è subentrata agli stati Uniti come co-leader del Sustainable Finance Working Group insieme alla Cina. Nonostante l’assenza di un comunicato ufficiale al termine della Ministeriale, sono proseguiti i lavori sulla riforma delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), sul miglioramento del Common Framework per la ristrutturazione del debito e sullo sviluppo di strumenti per moderare il costo del capitale in Africa. La discussione ha evidenziato anche l’urgenza di riformare le regole del commercio globale e di restituire centralità al multilateralismo, mentre temi come la tassazione sono rimasti sullo sfondo.
Parallelamente, il Brasile – Paese che ospiterà la COP30 – ha iniziato a costruire il percorso verso Belém organizzando il primo incontro del Circle of Finance Ministers, una piattaforma che riunisce 25 Paesi per sostenere l’attuazione della Roadmap da Baku a Belém, con l’obiettivo di mobilitare 1.300 miliardi di dollari entro il 2035. Le priorità: riforma delle BMS, strumenti finanziari innovativi, rafforzamento dei quadri normativi e nuove piattaforme-paese per attrarre investimenti sostenibili. Una roadmap ambiziosa, che riconosce, sulla scia dell’ultimo G20 a guida brasiliana, il ruolo fondamentale dei ministri delle finanze nell’azione climatica.
Crisi del debito: in cerca di coraggio politico in vista della Quarta Conferenza sul Finanziamento allo Sviluppo (FfD4), a Siviglia
Con un debito pubblico globale destinato ad aumentare ulteriormente di 2,8% punti di PIL nel 2025 e a superare il 100% del PIL entro la fine del decennio, il tema della sostenibilità del debito continua a rimanere centrale. Durante gli Spring Meetings 2025, si è parlato molto della necessità di come affrontare la crisi attuale, ma pochi strumenti concreti sono stati messi sul tavolo.
Il Fondo Monetario Internazionale ha presentato il Restructuring Playbook, una guida operativa per i Paesi debitori che intendono avviare una ristrutturazione del proprio debito. Si tratta di un contributo utile in termini di chiarezza e trasparenza, ma che non affronta i nodi strutturali del Common Framework del G20, ancora troppo lento, poco efficace e privo di forza vincolante.
Alcune proposte considerate “tecnicamente e politicamente praticabili” nel contesto attuale sono emerse durante l’evento pubblico “Finding a way out of the debt morass”, presentate dal gruppo di esperti ONU sul debito, co-presieduto da Paolo Gentiloni e Mahmoud Mohieldin: dalla riprogrammazione delle scadenze di pagamento e swap per ambiente ed educazione, al rafforzamento del Common Framework del G20, fino alla creazione di un “Club dei debitori” per riequilibrare i rapporti di forza con i creditori e dare una voce collettiva ai Paesi più indebitati.
Durante un evento organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Columbia University, il Ministro delle Finanze spagnolo Carlos Cuerpo ha illustrato tre proposte concrete nel contesto della Sevilla Platform for Action, in vista della Conferenza FfD4 di Siviglia. Tra queste: una Debt Pause Alliance pensata per sospendere temporaneamente i pagamenti sia sul debito pubblico che su quello privato in situazioni di crisi, un Debt Swap Hub per facilitare le conversioni del debito in investimenti sostenibili, e un nuovo fondo fiduciario da 100 miliardi di dollari alimentato dai Diritti Speciali di Prelievo (SDR) per aiutare paesi in sofferenza debitoria.
A ribadire l’urgenza di un approccio integrato tra debito, natura e clima è stato anche il rapporto finale del gruppo di esperti su Debito, Natura e Clima “Healthy Debt on a Healthy Planet”. Tra le raccomandazioni principali: incorporare in modo sistematico le considerazioni ambientali e climatiche nelle analisi macroeconomiche e fiscali (a partire dal rinnovamento della metodologia di analisi della sostenibilità del debito del FMI); promuovere ristrutturazioni del debito legate a investimenti verdi; estendere pratiche già esistenti come i debt-for-nature swaps; e mobilitare capitale privato attraverso nuovi strumenti, inclusi veicoli speciali che emettano obbligazioni garantite da aiuto pubblico futuro, e rafforzare la capacità dei Paesi di gestire il debito in modo sostenibile, anche attraverso riforme fiscali verdi. L’obiettivo è chiaro: permettere ai Paesi di uscire dalla trappola del debito senza sacrificare le priorità climatiche e di sviluppo.
Infine, la proposta dell’IISD Debt for Resilience Initiative (D4R) offre un’alternativa che sposta il focus dalla semplice solvibilità alla sostenibilità esterna. L’iniziativa mira a prevenire aggiustamenti disordinati e a combinare la riduzione del debito con investimenti in resilienza climatica, in coordinamento con FMI e Nazioni Unite. Il meccanismo riprende alcuni elementi dell’iniziativa HIPC, ma li aggiorna per rispondere alle sfide attuali, inclusa la necessità di garantire che la finanza pubblica non ostacoli, ma accompagni, lo sviluppo sostenibile.
Si tratta di idee concrete, spesso tecnicamente solide e supportate da un crescente consenso tra esperti e società civile. Ma senza un vero motore politico alle spalle, rischiano di restare lettera morta. La sfida, ora, è trasformare questo fermento tecnico e diplomatico in volontà politica condivisa. La prossima tappa sarà la Quarta Conferenza sul Finanziamento allo Sviluppo (FfD4), a Siviglia: un banco di prova per verificare se la comunità internazionale è pronta a rispondere con serietà alla crisi del debito, mettendo al centro giustizia fiscale, sostenibilità e solidarietà globale.
Foto di IMF photo, Spring Meetings 2025